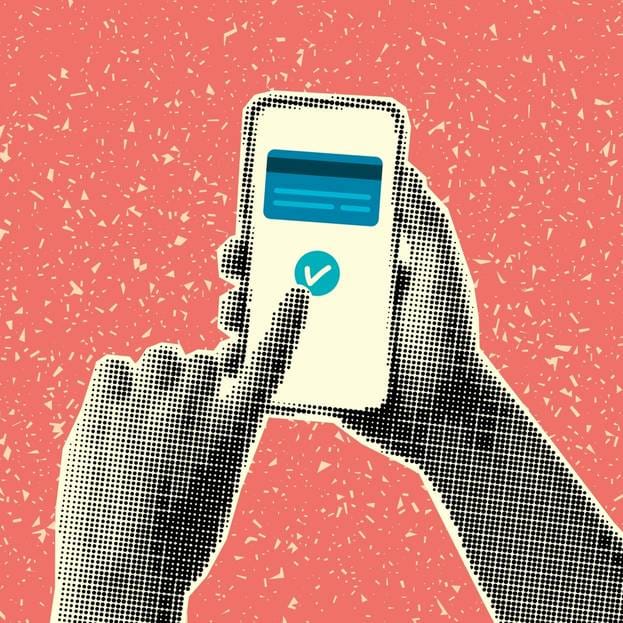Una volta, tanto tempo fa, al liceo mi ritrovai di fronte, nella traccia di un tema, una citazione presa da «Avere o essere?» di Erich Fromm, filosofo e psicanalista tedesco. In questo libro espone una distinzione fra una modalità di vivere centrata sull’avere – propria del consumismo, in cui è facile dare molta importanza a ciò che si ha – e una modalità centrata sull’essere, quindi più profonda e radicata in sé e per questo più stabile. Ritengo che questa distinzione sia ancora attuale, ma probabilmente necessiti di un aggiornamento. Anche perché siamo sempre più immersi in un consumismo che amplia la distanza tra chi possiede molto e chi, invece, ha quasi nulla. Chi si trova in quest’ultima condizione finisce per avere ben poco, se non niente, con cui identificarsi secondo la logica dell’avere. E, dato che la modalità dell’essere è più impegnativa e controcorrente, cosa resta?
Restano, ad esempio, la modalità del fare e quella dell’apparire che talvolta, complici i social network sempre a portata di mano (e di occhi), finiscono per intrecciarsi nel «mostrarsi mentre si fa». L’ossessione del fare, il «dover fare», ha la sua manifestazione più evidente nella cosiddetta «FOMO », Fear Of Missing Out, la paura di perdersi qualcosa, che a volte diventa una sorta di «bulimia» dell’esperienza da fare a tutti i costi, per paura di restar esclusi.
Da qui nascono fenomeni come enormi gruppi virtuali su app di messaggistica, a volte con centinaia di membri, per lo più fra sconosciuti immagino, dedicati alla segnalazione di eventi, alla condivisione e alla ricerca di «qualcosa da fare». C’è qui qualcosa di primordiale e antico, legato al fatto che, mentre la tecnologia si è evoluta a grande velocità, con un’accelerazione esponenziale, il nostro sistema di corpo e mente è cambiato poco da quando eravamo scimmiette nella foresta: restiamo primati, col primato della tecnica. Per cui venire esclusi, restare fuori dal gruppo, significa essere esposti al pericolo, diventare facili prede, morire. E la morte, la fine, sono le cose che più ci spaventano.
Inizia così una corsa, una rincorsa agli eventi in cui bisogna esserci. E se la motivazione non è endogena — non nasce cioè da un desiderio autentico e interiore di fare un’esperienza — ma è esogena, alimentata dalla FOMO e da quella paura profondamente animale e umana dell’esclusione, allora può emergere il bisogno di dimostrare di esserci stati, di aver partecipato. E qui i social network giocano il loro ruolo, e se lo giocano da padroni.
È sempre più frequente la presenza di smartphone a registrare la testimonianza di un’esperienza (è quasi più raro il contrario, tanto che un artista del calibro di Bob Dylan è arrivato a vietarli ai suoi concerti). Non mi riferisco solo a una foto ricordo, un’istantanea, ma al porre costantemente uno schermo fra sé e l’esperienza, idealmente per «immortalarla», ma di fatto schermandoci, isolandoci da questa. Usiamo la parola schermo soprattutto per indicare la superficie di un dispositivo, luminosa o illuminata, su cui compaiono immagini che vogliamo vedere, come gli schermi di televisori, smartphone o computer, cinema. Ma «schermo» indica anche e soprattutto qualcosa che protegge e, in qualche modo, separa o isola. C’è un controsenso quindi fra il voler vivere un’esperienza e il separarci da questa, ponendo uno schermo in mezzo?
Forse una chiave di comprensione sta proprio in una parola che ho usato poco fa: «immortalare» che contiene in sé l’idea, illusoria, di un’immortalità sebbene limitata a un’immagine. Come se, consapevoli dell’inaffidabilità della nostra memoria e dell’impermanenza delle tracce mnestiche (le «registrazioni» dei ricordi nel nostro cervello), sentissimo di doverle registrare su un supporto che ci appare più solido. Il problema è che così l’esperienza viene vissuta filtrata e riflessa su uno schermo (tralasciando il fatto che raramente riguardiamo le migliaia di foto che facciamo e che i supporti possono comunque rompersi o andare perduti). Come se la paura di morire ci portasse da un lato a accumulare attività e immagini o tracce digitali di queste, facendoci però perdere, almeno in parte, il vivere pienamente quelle esperienze.
Una possibile soluzione, la mia modesta proposta, sta nell’accettare la fine, nostra, della nostra memoria e del nostro ricordo. Lasciando andare l’ossessione del fare e registrare tutto, possiamo dedicarci appieno, «anima e cuore» al vivere l’esperienza. Questo per me, psicoterapeuta corporeo, si può tradurre con vivere completamente «nella psiche e nel corpo» un’esperienza. Se poi il ricordo narrativo di questa si degrada, poco importa, l’esperienza resta vissuta e lascia comunque una traccia nella nostra storia. Un buon esempio di questo è ciò che accade nei sogni: non possiamo registrarli in alcun modo, eppure ci sono sogni che ricordiamo per tutta la vita e che, in qualche modo, ce la cambiano. Ci sono anche sogni che, pur non ricordandoli, hanno avuto comunque un’influenza profonda nella nostra psiche.
Un’altra soluzione, sempre possibile, è non far niente, e rischiare la noia, un sentimento oggi tanto vituperato e evitato, come se stessimo perdendo la capacità di non far nulla, di lasciar scorrere liberamente l’attenzione senza che sia catturata da uno stimolo esterno (solitamente, oggi, uno schermo), e lasciare che vada potenzialmente verso dentro di noi. Eppure, a volte, è proprio dalla noia che possono nascere intuizioni o soluzioni creative. Quando siamo fermi, insomma, la nostra psiche non viene sovrastimolata e sovraccaricata da stimoli continui e può creare. Spesso il vuoto ci richiama quell’esclusione minacciosa di cui scrivevo poco sopra, ma in realtà è spazio e tempo liberi per qualcosa di nuovo.