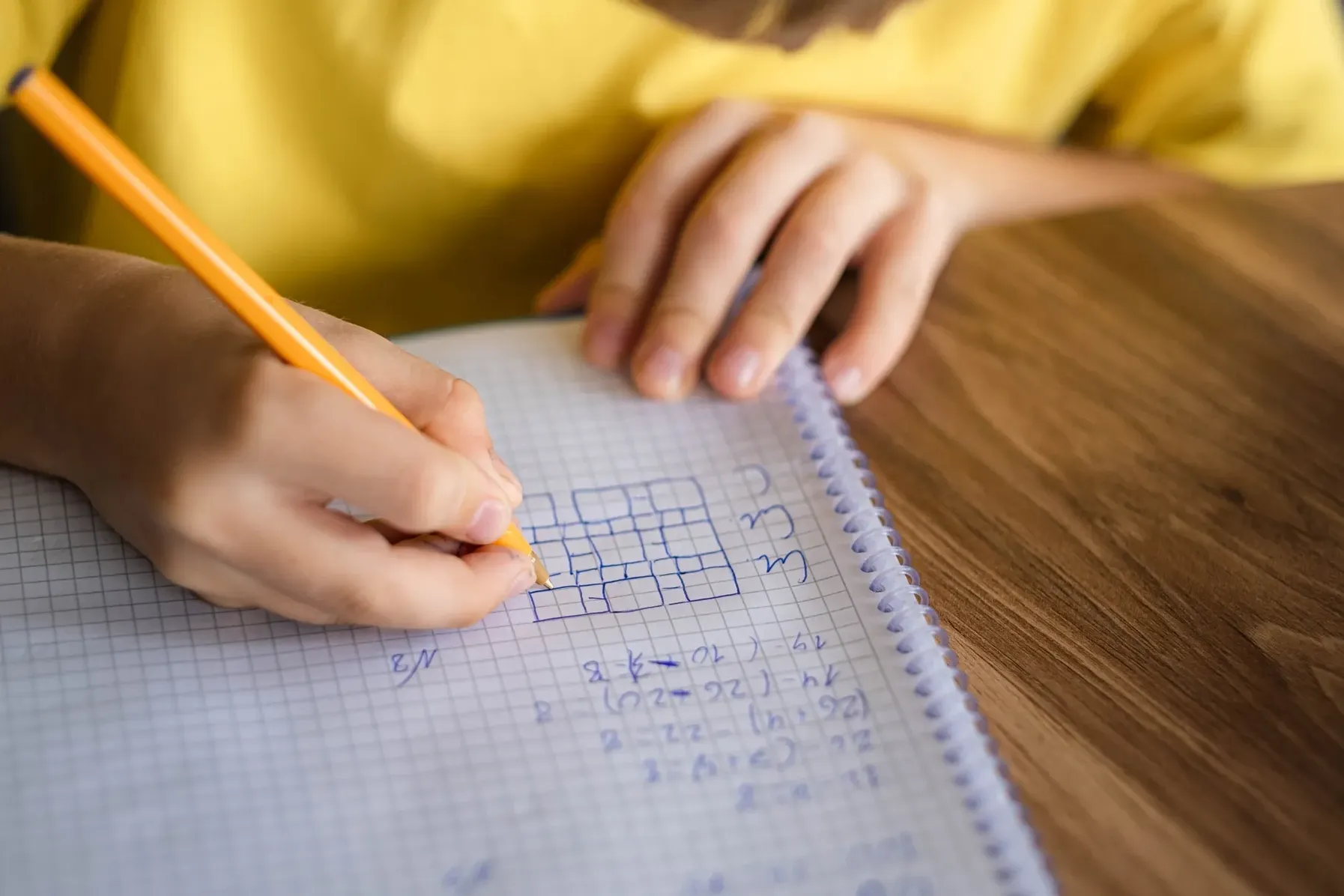L’anno scorso, all’inizio della seconda elementare, mio figlio e i suoi compagni, su indicazione della maestra, presero cartoncino, forbici, pennarelli e fermacampione per realizzare un finto orologio ed esercitarsi a leggere l’ora.
Per un tempo che a me è sembrato infinito – ma è durato probabilmente meno di una settimana – io e mio marito ci siamo alternati la sera per cercare di fare entrare nella testa di mio figlio il concetto delle 12 ore che si ripetono, spiegando questioni come “le tre meno un quarto” (che si possono chiamare anche due e tre quarti o 14.45 o persino 2.45 se parliamo delle ore notturne), riflettendo su quanti minuti, quarti d’ora e mezz’ore ci sono in un’ora, e disperando ogni volta che nostro figlio di 7 anni sembrava non afferrare concetti elementari tipo: «Se arrivo fra 30 minuti, che ore sono?» oppure: «A che orario corrispondono le 20.40?».
«Non ci arriva proprio», ci dicevamo sgomenti. Finché non ha fatto quello scattino di comprensione, ha capito il meccanismo, è diventato sicuro. Poi gli abbiamo comprato un orologino da polso e ha iniziato a scandire le ore della giornata con la fastidiosa precisione di Furio: «Mamma, avevi detto che arrivavi alle cinque e un quarto e invece sei arrivata alle 17,21, hai 6 minuti di ritardo».
Ci ho pensato quando ho letto che le scuole in Inghilterra stanno rimuovendo gli orologi dalle classi, perché i bambini non riescono a capire l’ora, e anche i liceali hanno difficoltà a leggere l’ora con le lancette. Credevo fosse una mezza bufala da tabloid, di quelle confezionate ad arte per dimostrare quanto sono debosciate le nuove generazioni, ma poi l’ho letta anche sulla BBC e mi sono rassegnata: l’orologio analogico è anacronistico. Del resto a cosa serve, se ovunque troviamo l’ora scritta comodamente in numeri?
«A cosa serve?»
«A cosa serve?» è la domanda che più mi infastidisce ogni volta che si parla di scuola. La sola risposta da dare, possibilmente in tono sprezzante, è: «A niente». Pochissimo di quanto si impara a scuola ha un’utilità immediata o tangibile, e per fortuna è così. Viva i sumeri, la proprietà commutativa, la fotosintesi clorofilliana e il quadrato costruito sui cateti.
«A cosa serve sapere scrivere le maiuscole in corsivo?» A niente, ma cos’hai di meglio da fare? A niente, ma magari impari a tenere in mano la matita con grazia. «A cosa serve imparare la poesia a memoria?». A niente, ma magari è bella (non sempre). A niente, ma così impari a tenere a mente qualcosa di diverso dai nomi dei calciatori.
Certo, ci sono anche saperi che un minimo di valenza pratica la hanno: imparare a leggere un orologio è uno di questi. Un’abilità che da grande ti permetterà di non fare la figura del perfetto idiota, anche se non servirà direttamente a guadagnare dei soldi o trovare lavoro (ma voi assumereste mai qualcuno che non sa leggere l’ora?). Quelle ore spese a comprendere il funzionamento delle ore mio figlio avrebbe potuto spenderle in maniera più rilassata, ma certamente non migliore.
L’autostima
C’è un grande equivoco del nostro tempo: che l’autostima si costruisca lodando i bambini: «Bravo, bravissimo. Bello, bellissimo». Io capisco chi non si è mai sentito apprezzato dai propri genitori, e non vuole commettere lo stesso errore. Non mi addentro nel dibattito se sia giusto o meno dire «brava» e «bella» (Le insegni a cercare l’approvazione altrui? Poni troppa attenzione sull’aspetto fisico? Sei troppo attenta alla performance? Veicoli stereotipi sessisti?). Personalmente penso sia comunque meglio lodare i bambini e le bambine che insultarli o non considerarli, ma non è questo a renderli sicuri di sé.
Un bambino sviluppa autostima quando scopre di essere capace. Sperimenta un senso di fiducia in sé stesso quando riesce a raggiungere un obiettivo, soprattutto se è un obiettivo inizialmente difficile e sfidante. Quando mio figlio non capirà le divisioni in colonna o si confonderà con l’analisi logica o cadrà dai pattini a rotelle potrò dirgli: «Ti ricordi quando hai imparato a leggere l’orologio? Non ci sei riuscito subito, ma poi ce l’hai fatta. C’è voluto impegno». Meglio ancora, se lo ricorderà da solo.
Volete preparare i bambini ad affrontare al meglio la prima elementare? Insegnate loro ad allacciarsi le scarpe piuttosto che a scrivere l’alfabeto. Due precisazioni: “piuttosto che” è usato in senso avversativo e il consiglio non è mio, ma di un’amica maestra. È frustrante e difficile mettersi ad armeggiare con i lacci, specialmente per bambini che non sono più abituati a fare nulla con le mani (cucire, intagliare, impastare, annodare…), proprio per questo è utile, e permette di sentirsi “più grandi”.
Non abbassare le richieste
«Vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può imparare ridendo?» questa bella citazione di Gianni Rodari è fra le peggio interpretate da oltre 60 anni. Certo che la scuola non deve più incutere terrore come un tempo, certo che con serenità d’animo si impara meglio, certo che ci sono tante diverse splendide strategie didattiche (che non conosco perché non è il mestiere mio), ma questo non esclude che studiare costi fatica, che ci sia piacere nell’impegnarsi e soddisfazione nel riuscire a fare qualcosa che prima non si sapeva fare. E che è difficile divertirsi quando le cose sono troppo facili.
Oggi invece abbiamo la pretesa che i bambini siano intrattenuti, stimolati, divertiti, ma mai che facciano troppa fatica. I compiti? Sempre eccessivi. Imparare a memoria? Abominio. Il corsivo? Tanto useranno il pc. Il problema è difficile? La maestra l’ha spiegato male, oppure il bambino avrà qualcosa che non va, andiamo dal dottore.
Un altro grosso equivoco è che pretendere di tenere “alta” l’asticella sia poco inclusivo. A parte il fatto che dovremmo intenderci su quale sia questa altezza (è pretendere troppo sapersi allacciare le scarpe? Leggere l’orologio? Scrivere in corsivo? Fare i compiti? Imparare a memoria le tabelline?), si tratta - come dice il motto dei lupetti scout – di fare «del nostro meglio». Ma quale sia il meglio dei nostri figli continuiamo sempre a sottovalutarlo, e se qualcuno di esterno alla famiglia ci aiuta a scoprirlo ci fa un piacere.
«Quello che hai meno voglia di fare è quello di cui più hai bisogno». Quest’altra citazione – invece – viene dalla mia insegnante di pilates, corso cui mi sono iscritta da brava quarantenne. Mai stata elastica, mai avuto senso dell’equilibrio, detesto quasi tutti gli esercizi, ma so che mi fanno bene. Vorrei dirvi dei miei incredibili progressi, ma non ce ne sono stati. Però la schiena mi fa un po’ meno male, e se fossi rimasta sul divano sarebbe stato peggio. Cos’è crescere se non fare anche le cose che non si vogliono fare? Non è mai troppo tardi né troppo presto per impararlo.