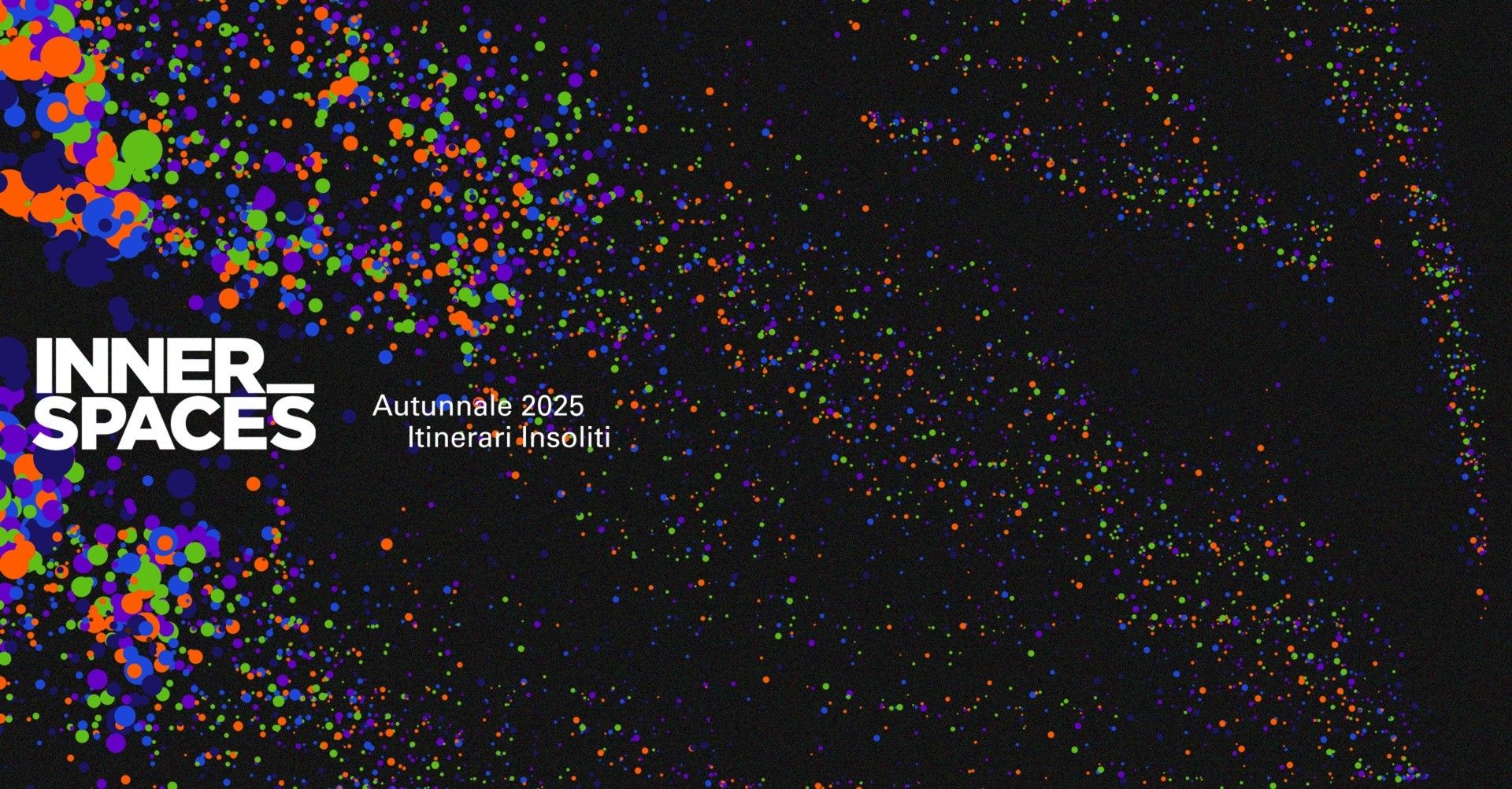Nel cuore di Milano, l’Auditorium San Fedele ospita dal 2012 «Inner_Spaces», festival di musica elettronica sperimentale e arti audiovisive. A guidarlo è padre Antonio Pileggi, gesuita, musicista e musicologo, che ne ha fatto un luogo di incontro tra spiritualità, ricerca e innovazione sonora. Lontano da ogni confine di genere o di epoca, il festival invita a un’esperienza d’ascolto profonda e collettiva, in cui la musica diventa occasione di scoperta. In questa conversazione, padre Pileggi racconta la sua visione della musica, il valore educativo dell’ascolto e la possibilità di ritrovare, nel suono, un luogo condiviso di umanità.
LL: Guardando al programma del festival sembra emergere una trama di relazioni più che un semplice dialogo tra stili. È in questa tensione, che tiene insieme e non annulla le differenze, che si riconosce l’identità di «Inner_Spaces»?
AP: La varietà di epoche storiche e di generi è legata, prima di tutto, a una riflessione sul patrimonio. Il festival dedica grande attenzione alle nuove commissioni, ma è importante ricordare che ogni creazione nasce da una storia, da una memoria. Noi avanziamo nel tempo non semplicemente rinnovandoci, ma portando con noi saperi e conoscenze pregresse. Categorie umane come la testimonianza e la memoria, oggi, in un mondo frammentato e dominato dall’urgenza del presente, rischiano di essere dimenticate. In questo senso, l’impegno culturale del festival, che si esprime in un programma capace di intrecciare musica occidentale e orientale, antica e contemporanea, è quello di ricondurre l’umanità nella storia, creando una sorta di fraternità tra esperienze musicali e umane differenti. Il dialogo tra forme e linguaggi all’interno degli stessi programmi consente inoltre di attivare nuove conoscenze, mostrando come alcuni repertori possano ancora parlare e risuonare nell’anima e nel cuore dell’uomo di oggi.
LL: L’edizione in corso è intitolata «Itinerari insoliti». Come spiegherebbe, a chi si avvicina per la prima volta a «Inner_Spaces», cosa significa vivere “un itinerario insolito” in termini di esperienza d’ascolto?
AP: Ogni stagione è un itinerario che intende creare un’esperienza di ascolto attorno a una tematica precisa. È un percorso fatto di tappe e di passaggi, un attraversamento da un punto all’altro alla scoperta della musica. Queste tappe conducono spesso a spaesamenti sonori, tra repertori confinanti o dialoganti, capaci però di generare simmetrie nuove, talvolta rovesciate, di aprire mondi sonori inattesi e immaginari nuovi, a volte utopici, altre volte distopici. Sono percorsi che cominciano in un luogo e si concludono in un altro, tracciando un cammino di trasformazione nell’ascolto.
LL: La sua formazione musicale è classica, ma la direzione di «Inner_Spaces» la porta nel cuore della sperimentazione sonora. Qual è, per lei, il punto di contatto, o di passaggio, tra la musica cosiddetta classica e quella elettronica?
AP: Sono due mondi sonori diversi quello classico e quello elettronico. La scrittura musicale classica dal Seicento in poi, ma soprattutto negli anni delle avanguardie della seconda metà del Novecento, si evolve rapidamente e con un dettaglio puntualissimo, e il livello di scrittura è tale che richiede grande attenzione e grande conoscenza per essere apprezzato e compreso; mentre la musica elettronica ha un’evoluzione più lenta, con suoni che si trasformano più lentamente durante l’esecuzione. Per questa differenza di velocità che si ha maggiore difficoltà ad ascoltare la musica contemporanea strumentale. Mentre l’evoluzione più lenta, più dilatata, e la profondità del dettaglio più graduale, tipici della musica elettronica, sono aspetti più confacenti all’attenzione dell’uomo d’oggi. L’aspetto del tempo mi pare determinante: i tempi evolutivi lenti della musica elettronica premettono all’uomo d’oggi di cercare, nel suono, un immaginario che gli permette di trovarsi e di riconoscerci; mentre l’evoluzione dinamica veloce della musica classica o contemporanea ma strumentale, sembra non permettere all’uomo di ritrovarsi, pur nel paradosso di una scrittura musicale iper-ricca di riferimenti.
LL: L’esperienza d’ascolto che lei propone sembrerebbe chiedere una sorta di esercizio interiore: silenzio, concentrazione, tempo. Potremmo definire «Inner_Spaces» una scuola di ascolto?
AP: È proprio nelle nostre intenzioni. Il festival è, da sempre, anche un progetto educativo, pensato per superare la logica della semplice fruizione. Per noi è fondamentale educare all’ascolto: un ascolto che lavora sulla memoria e, al tempo stesso, apre alla ricerca di nuovi itinerari e di percorsi capaci di generare esperienze inedite.
LL: La sala dell’Auditorium San Fedele è dotata di un impianto speciale, l’Acusmonium, progettato per spazializzare il suono. In che modo l’ambiente acustico diventa parte del significato musicale?
AP: L’ascolto umano non è semplicemente frontale: noi percepiamo e comprendiamo le diverse provenienze del suono. L’apparato percettivo dell’uomo è, per questo, straordinariamente elaborato. L’Auditorium è uno spazio pensato per ricreare e amplificare queste capacità, offrendo un’esperienza di percezione sonora immersa nel reale. Attraverso artifici come l’interpretazione e l’impianto speciale, si arriva a una ricomposizione di ciò che naturalmente l’uomo è in grado di cogliere in uno spazio acustico. Questa prospettiva d’ascolto, sostenuta anche dall’esercizio del silenzio, aiuta ad entrare in un’esperienza uditiva unica, più consapevole e profonda.
LL: L’Acusmonium, con i suoi altoparlanti disseminati nello spazio, sembra trasformare la sala in un corpo sonoro. Cosa accade quando il suono non proviene più da un punto ma diventa ambiente, respiro, architettura?
AP: Accade che si crei la condizione per un ascolto non più solitario, ma comunitario, capace di generare, come in un corpo, una relazione viva tra le diverse parti: il suono, la musica, l’ascoltatore, il musicista, lo spazio e il silenzio.
LL: Molti autori, da Walter Benjamin a Luigi Nono, hanno visto nella musica un gesto politico. Che cosa significa per lei “resistere” attraverso il suono oggi, in una società così satura di rumore e così povera di ascolto?
AP: Il Centro Culturale San Fedele nasce nel 1945 per volontà del cardinale Ildefonso Schuster (Arcivescovo metropolita di Milano dal 1929 al 1954, ndr) che chiamò i Gesuiti a ricostruire, attraverso la fede e l’arte, un dialogo con la città lacerata dalla guerra. Il nostro impegno, anche oggi, si radica in quella chiamata originaria: cercare, tramite i linguaggi artistici, punti di incontro che possano unire le persone. Il tempo passa, la società cambia, e ciò che oggi ci sembra più urgente – in un mondo liquido, attraversato da nuovi bisogni – è far comprendere e sperimentare che non siamo elettroni dispersi nel mondo, ma uomini dotati di memoria, chiamati a riscoprire una dimensione personale. L’uomo contemporaneo ha smarrito alcuni riferimenti essenziali: il nostro compito è offrire strumenti e occasioni che lo aiutino a ricostruirli, per comprendere più a fondo chi siamo.
LL: Chi è oggi il pubblico di «Inner_Spaces»? E c’è un pubblico che ancora non si è avvicinato a questa esperienza d’ascolto e che lei vorrebbe raggiungere?
AP: Il festival è seguito principalmente da un pubblico tra i venti e i quarant’anni: professionisti, studenti e persone che hanno già un certo contatto con la musica. Ogni concerto, però, ha una sua specificità, e questo porta con sé una continua trasformazione del pubblico.
Mi piacerebbe poter replicare alcuni concerti capaci di suscitare interesse in un pubblico più vasto, per favorire una partecipazione ancora più ampia e diversificata. La vera sfida riguarda la fascia d’età tra i diciotto e i venticinque anni, una fascia difficile da raggiungere: i post-adolescenti sono in una fase di ricerca e le loro scelte sono spesso influenzate da amicizie, famiglia e contesto di provenienza, oppure ancora troppo volubili. Mi piacerebbe partire proprio dall’ascolto della loro musica e dei loro interessi per creare nuove proposte, capaci di attivare esperienze di scoperta e di stupore, che permettano anche ai più giovani di avvicinarsi e di intraprendere i loro personali «itinerari insoliti».
LL: Lei ha raccontato che all’inizio non era credente e che poi, nel cammino vocazionale, è diventato padre gesuita. In che modo quella conversione ha influenzato il modo in cui ascolta e propone la musica?
AP: C’è stata una conversione tra il 1995 e il 1998 a Parigi: un incontro con Cristo, che è durato un po’ di tempo con l’ascolto del Vangelo e la ripresa dei Sacramenti. Sono entrato nei Gesuiti nel 1998, con l’intenzione di abbandonare tutto e di non fare più quello che facevo prima. Per questo per tantissimi anni non ho fatto più musica. Sono stati anni che mi hanno permesso di ripensare l’ascolto, non più in termini fruitivi e mondani, come risposta a un bisogno personale, ma come esperienza. L’ascolto come strumento per entrare nell’esperienza personale, come ascolto di qualcosa che porta con sé sia un mistero sia una grazia. L’invito della Bibbia ad ascoltare mi ha aiutato a riscoprire l’ascolto su nuove basi, e negli ultimissimi anni ho approfondito quella dimensione che si trova nel libro dei Salmi, soprattutto in quelli dal 49 all’85, dove compaiono riferimenti alla musica — la cetra, i flauti, i cembali — e dove la musica si rivela come lode universale.
LL: Mi viene da pensare a una sorta di «conversione acustica». In che senso, secondo lei, l’ascolto può essere la prima forma di relazione con una presenza? È un atto solo spirituale, o anche un atto profondamente umano, un modo di abitare il mondo insieme agli altri?
AP: La dimensione dell’ascolto è parte fondamentale della relazione umana. Si pensi al bambino e al rapporto che ha con la voce materna sin dalla sua vita nel grembo. L’ascolto è parte costitutiva dell’essere umano. È per questo che l’ascolto ci permette di entrare relazione, meglio di altri strumenti, con l’altro. Nella fede cristiana, poi, è proprio la Parola di Dio – il Logos, il Verbo – ad essersi fatta carne. Quindi entrare in relazione con l’altro, che anche mistero, è un’azione profondamente spirituale.
LL: Nelle sue interviste ricorre spesso l’idea che la musica non rappresenti ma riveli. Se la musica rivela, che cos’è allora, per lei, il suono?
AP: Il suono è, innanzitutto, un parametro: nella sua semplicità, una categoria fisica che può essere descritta attraverso elementi come l’altezza o il timbro. Tuttavia, il suono in sé non basta per accedere alla profondità del discorso musicale, perché il linguaggio della musica è una manifestazione epifanica. Esso rivela qualcosa che ci oltrepassa e che, nello stesso tempo, appartiene intimamente alla nostra natura umana: da un lato perché nasce da una realtà fisica, dall’altro perché è espressione dell’uomo stesso.