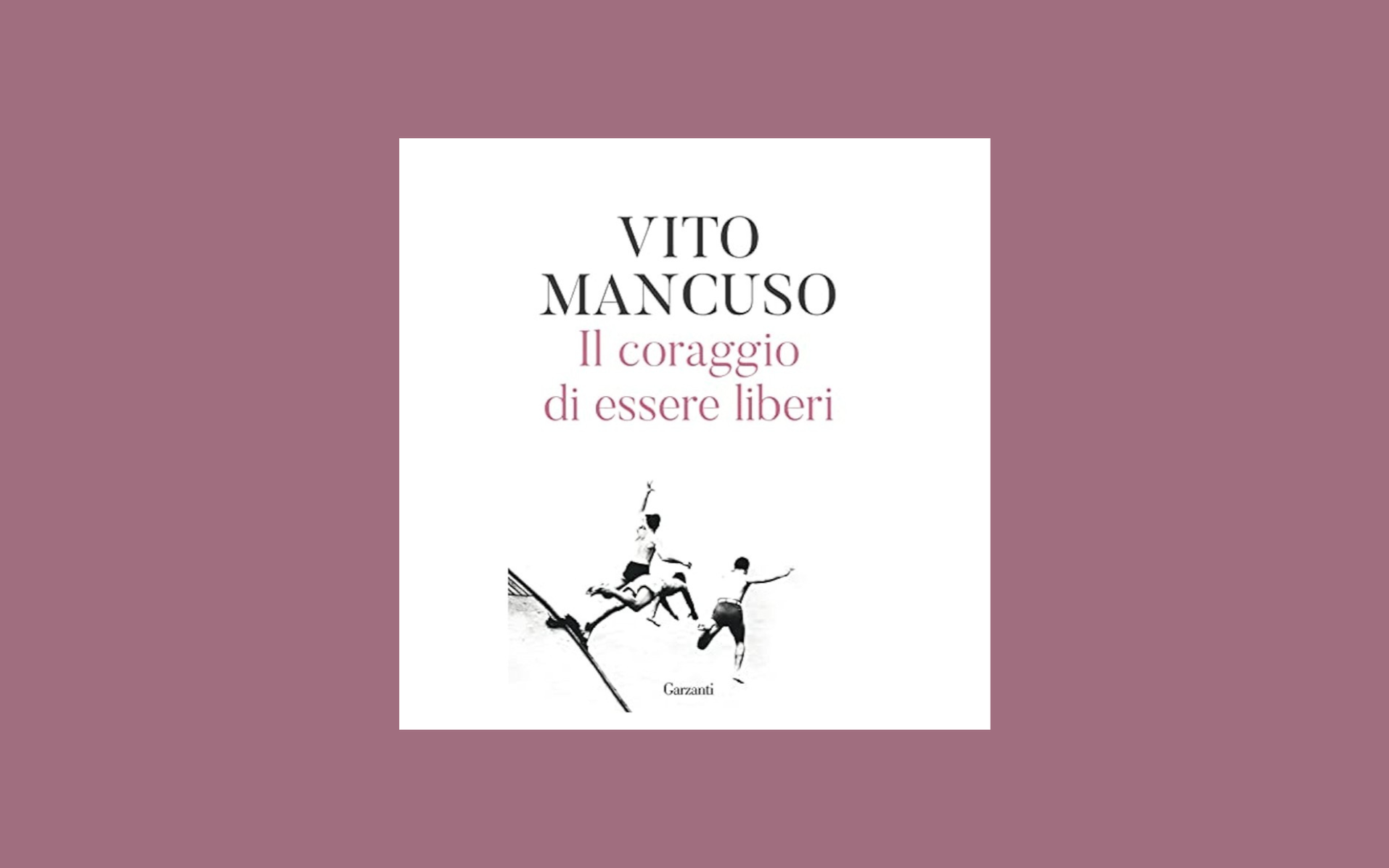«N essuno conosce Dio se prima non conosce sé stesso», afferma in uno dei suoi celebri sermoni Meister Eckhart. Ma come poter conoscere sé stessi se prima non si è scrutato a fondo la propria anima? Del resto, secondo il teologo Vito Mancuso, che, alle ore 20.45 di mercoledì 10 settembre, presso l’Aula Magna di Sant’Agostino, sarà ospite di «Molte fedi sotto lo stesso cielo» con la lectio magistralis «Ricomincio da me. Sul senso del lavoro interiore», è proprio nelle profondità del nostro sentire che può concretizzarsi l’incontro con Dio.
FR: L’edizione 2025 di «Molte fedi sotto lo stesso cielo» si intitola «Crash! Un pianeta su cui ricominciare». Il mondo è andato in frantumi?
VM: L’evoluzione, che caratterizza questa realtà, prosegue senza interruzioni ma rivela un prezzo che, del resto, c’è sempre stato. Un organismo, infatti, può raggiungere uno stadio superiore solo tramite una serie di tentativi e di errori. Tutto ciò si evince a livello naturale (penso, per esempio, alle malattie genetiche), ma anche a livello storico: il mondo, storicamente, continua a progredire ma, allo stesso tempo, produce dolore, ingiustizia e vittime innocenti. La logica con cui storia e natura avanzano (in modo assolutamente non gratuito) prevede la frantumazione.
FR: C’è, secondo lei, un «peccato originale», se così si può dire, per il quale, ultimamente, viviamo tempi così drammatici?
VM: Non credo a nessun tipo di peccato originale e non penso nemmeno che la storia sia una catastrofe. Vi sono delle catastrofi ma esse sono direttamente o indirettamente funzionali a quel fenomeno prezioso che è la consapevolezza, intesa come coscienza che rettamente capisce e rettamente agisce. Certo, se si guarda ai nostri giorni non si può non dire che la consapevolezza dell’umanità sia meno vivida e meno pulsante di un tempo. Ma è anche vero che certi diritti, che una volta ci sognavamo, oggi sono affermati e tutelati. Nonostante le difficoltà (e dolori irrazionali e ingiustificabili), si può parlare, a mio avviso, di un progredire verso un’unione di fedi e di popoli e verso una pace perpetua. Se diamo un’occhiata a quanto raggiunto, possiamo guardare ai tantissimi problemi che abbiamo davanti con il giusto ottimismo.
FR: Il titolo della serata a cui parteciperà, invece, sarà «Ricomincio da me. Sul senso del lavoro interiore». Come poter ripartire da se stessi?
VM: Penso che il compito di ognuno di noi, soprattutto in un mese dell’anno come quello di settembre, dove ogni cosa riparte, sia quello di individuare il nostro «punto fermo», il fondamento, l’ubi consistam, ovvero il punto d’appoggio, non tanto per sollevare il mondo (come diceva Archimede), ma per non farci schiacciare dal mondo, con la sua carica di pessimismo, fatalità, rassegnazione. Bisogna riporre fiducia nei nostri desideri, tentando di comprendere quali siano le virtù che ci caratterizzano e quali le debolezze, ma soprattutto sforzandoci di capire quale sia il nostro «distributore di speranza», così da potere attingere a esso ogni volta che vogliamo. Con cosa nutro la mia progettualità e la mia idealità? Dove prendo il cibo necessario per la mia anima? Queste sono le domande da porsi. Citando il cardinal Martini (che citava, a sua volta, sant’Ignazio di Loyola), bisogna saper mettere ordine nella propria vita.
FR: La teologia come psicologia?
VM: Se la teologia non muta (anche) in psicologia, traducendo tutta la sua cattedrale dogmatica (encicliche, bolle concili…) in esercizio spirituale, non solo non serve a nulla ma può anche diventare dannosa: non una ruota che aiuta a camminare bensì una ruota che schiaccia gli esseri umani, rendendoli infelici e cattivi, nonché poco inclini a sorridere alla vita. Per psicologia, non mi riferisco tanto a quella moderna, volta allo studio e al governo della psiche, ma a quella classica, volta allo studio e al governo dell’anima (che è poi proprio quel che significa la parola greca psyché).
FR: In un articolo pubblicato il 24 agosto per La Stampa, lei, citando Dostoevskij, si dice convinto che la bellezza possa salvare il mondo. È davvero così?
VM: Non so se possa salvare la società umana, ma può salvare il nostro mondo interiore. La bellezza ci salva infatti dal narcisismo, perché ogni esperienza estetica autentica è anche un’esperienza estatica, in quanto ci dice che esiste altro all’infuori di noi: ferisce quindi il nostro ego e, allo stesso tempo, lo purifica. La bellezza, facendoci capire che esistono grandi valori, ci salva inoltre dal nichilismo, ovvero dall’idea che non ci sia niente per cui valga la pena vivere. È, del resto, l’ideale greco della kalokagathia: ciò che è bello è anche buono. Infine, la bellezza ci salva dalla tecnocrazia e da quella modalità di presentare se stessi conforme a un estetismo formulato da altri; altri che si pensano come macchine, ubbidendo a comandi che arrivano da chissà quale altrove. La bellezza è sempre fatta a mano, non è seriale bensì unica. Perseguirla ci rende diversi da qualsiasi tipologia di artificialità e ci fa restare umani.
FR: Sempre per La Stampa, lo scorso maggio, lei, citando Norberto Bobbio, ha affermato che «la vera differenza non è tra chi crede e chi non crede, ma tra chi pensa e chi non pensa». La filosofia è superiore al kèrigma, l’annuncio del messaggio cristiano?
VM: Non sono d’accordo con la distinzione pascaliana fra il Dio della Bibbia e il Dio dei filosofi. A mio avviso, è una distinzione infondata. Il «divino» è unico ma si dà in modi plurimi: nella rivelazione ebraica, cristiana e coranica e in quella di altre religioni. E si dà anche nella ricerca filosofica. Il giovane Agostino, nel «De vera religione», afferma che ritenere che filosofia e teologia dicano la stessa cosa sia principio di salvezza. Tutto va pensato, anche il kerigma. Poi, ovviamente, c’è modo e modo di pensare: c’è chi afferma che la ragione debba avere la precedenza su tutto e chi, invece, è convinto che la ragione non sia sufficiente a comprendere l’esistenza nella sua totalità.
FR: Ne «Il coraggio di essere liberi» (Garzanti, 2016), lei affronta il tema della libertà. L’uomo può davvero essere libero?
VM: L’uomo può giungere alla libertà, ma il primo passo fondamentale per arrivarvi è capire che liberi non si è. Giacciamo nella «caverna», in un mondo esteriore che, come detto, progredisce ma con un prezzo da saldare terribile. Quando si comprende ciò, si giunge già a un gradino superiore poiché la libertà è sempre «libertà da». Poi, avviene il momento delle decisioni che, se coerenti, mutano in stile di vita e modo di essere che, non dovendo scegliere più, supera il libero arbitrio e, paradossalmente, diventa libertà di obbedire. L’idea di non fare il proprio dovere cessa di essere all’orizzonte, così come il musicista che, allenando incessantemente se stesso alla melodia e all’armonia, non può stonare. Ciò avviene anche nella propria moralità: ho conosciuto persone così libere da loro stesse la cui vita era diventata una forma di ubbidienza interiore. È la punta finale di una piramide. Ma prima bisogna avere il coraggio di dire no a tante cose.
FR: Lei ha concepito una «teologia cristiana della relazione». Gli uomini sono ancora capaci di relazione?
VM: Fortunatamente, sì. Questa nostra intervista, del resto, cosa è se non relazione? I sistemi umani (squadre sportive, aziende, associazioni) funzionano solo se gli uomini sono capaci di relazionarsi fra di loro. La fine delle relazioni sarebbe la fine dell’umanità, ma io la fine dell’umanità ancora non la vedo. Certo, esistono dei problemi, come la “trappola” degli smartphone, che irretisce le coscienze (soprattutto dei più giovani), ma anch’essa, a mio avviso, è il sintomo di un bisogno di relazione. È necessario che gli esseri umani abbiano fiducia gli uni degli altri: la nostra pasta è buona; non per nulla la teologia insegna che siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio.
FR: Martin Heidegger diceva: «Ormai solo un Dio ci può salvare».
VM: Sono d’accordo, ma da sempre. Dall’inizio della storia, gli esseri umani, tramite le loro religioni, hanno sviluppato il bisogno di salvezza. Heidegger, quando, durante l’intervista a Der Spiegel, pronunciò questa frase, sentiva l’abisso che si avvicinava; l’abisso in cui siamo caduti ora. La salvezza può arrivare solo dalla divinità.
FR: Dov’è Dio a Gaza?
VM: Dov’era Dio a Auschwitz? Dov’è Dio quando compare una malattia genetica? Dov’è Dio in una storia che sempre porta con sé tragedie inaccettabili? Questo interrogativo non mette in crisi il Creatore in quanto tale, ma certe pagine bibliche che presentano Dio come Signore degli eserciti, le cui mani reggono l’universo con le sue leggi. Una concezione che non mi appartiene e che critico duramente: la storia (caotica, disordinata, che miete vittime innocenti) non è guidata da Dio, ma da una logica impersonale che, come detto, tende a un’evoluzione. «In interiore homine habitat veritas», dice sant’Agostino: Dio si raggiunge sprofondando in noi stessi, attraverso la preghiera, la meditazione, l’esperienza estetica. E si trova dove è sempre stato: nell’anima dei giusti.