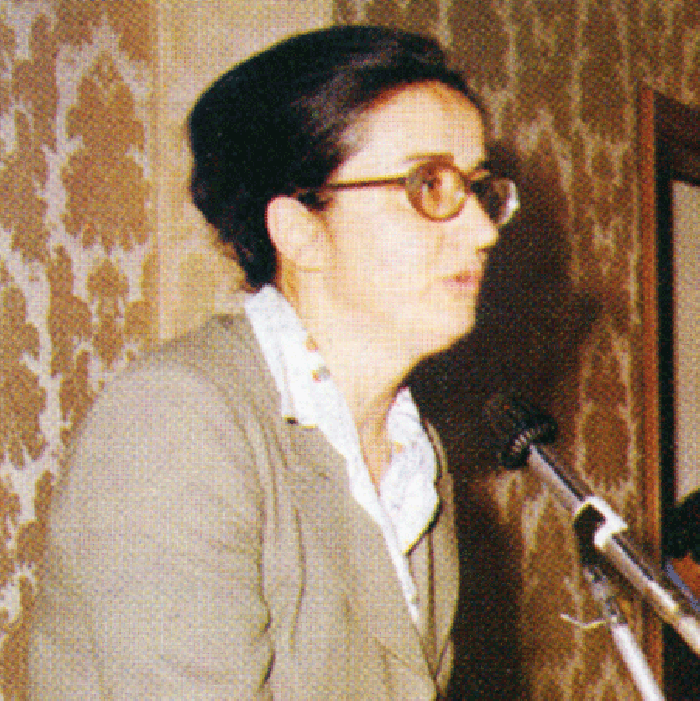Ogni vita un racconto / Bergamo Città
Mercoledì 26 Novembre 2025
Come le montagne, ognuna con il suo cielo
Gli studi, l’Università, la politica, i movimenti e il sacrificio di sé: sono state molte le donne capaci di cambiare le cose con la potenza del pensiero. Tra loro Vittoria Quarenghi che scrisse «Una vita val bene una vita»
Sembra un altro mondo, ma non è così distante. Molti di noi l’hanno sfiorato. Per affrontare l’avanzata delle istanze femministe nacque, nel 1967 la «Pagina della donna». Venne promossa da Giancarlo Zilio e confezionata da Amanzio Possenti, ma scritta e pensata, tra le altre, da alcune donne che ricordiamo per lo stile onesto e rigoroso e per il piglio battagliero: Vittoria Quarenghi che seppe interpretare lo spirito cristiano in ambito politico e Delia Borelli che animò il mondo scolastico con qualche incursione anche nel giornalismo. Si parlava di emancipazione e di liberazione; si sapeva, così come sappiamo anche oggi, che è impossibile arginare nelle pagine di un quotidiano il pensiero comune perché i mass media (oggi i social e l’AI), in particolare la televisione, diventavano determinanti. Per utilizzare al meglio questi nuovi linguaggi l’Università cattolica aprì in Città Alta, nella sede che è oggi dell’Università, la Scuola superiore di giornalismo e comunicazioni sociali, da dove uscirono giovani laureati formati sui nuovi linguaggi con l’obiettivo di preparare il futuro delle comunicazioni. E non è escluso che da qui siano partiti alcuni stimoli relativi ai temi di natura sociale poi affrontati dal nostro giornale. Per esempio il tema femminile con la donna che stava proseguendo il suo percorso verso l’indipendenza, l’impegno nel sociale e quello politico.
Era dunque doveroso dedicarle attenzione attraverso uno spazio particolarmente a lei dedicato. Vittoria Quarenghi frequentava questa scuola. E da qui sono uscite insieme a lei, Renata Del Gizzo (oggi vice presidente del Circolo Culturale G. Greppi) e la professoressa Delia Borelli a cui spettò il compito di scrivere il ricordo della senatrice morta a soli 50 anni nel 1984: «Credo – scriveva Borelli - che sia stato un sacrificio per Vittoria scegliere di fare politica perché, se è vero che lo sono tutti cristiani, è altrettante vero che nello stato del pluralismo delle idee, chi è eletto per scegliere deve farlo nel massimo rispetto per tutti, mantenendo la sua identità che può essere letta come limite. Lavorò nella scuola, nella cultura, nell’educazione; per un certo periodo si occupò dl Sanità, ma la sua grande, ultima battaglia fu quella per la vita contro l’aborto». Non solo in linea teorica, ma con l’azione. «Una ragazza in quel tempo era rimasta incinta; non voleva abortire, i suoi non la volevano più in casa ed era senza lavoro. Scrisse a L’Eco segnalando il suo caso. Fu messa in contatto con Vittoria Quarenghi. Dopo qualche mese, una telefonata al giornale: “Una bella notizia - era lei, Vittoria -: è nato un maschietto; la ragazza ha trovato lavoro ed è tornata con i genitori”. “Una vita val bene una vita” era il suo motto». Vittoria dedicò le ultime forze a parlare di lotta all’aborto. Arrivò, quasi senza forze a Valbondione e si fermò a Novazza dall’amica Anna Serena Pirola per una giornata bellissima fra e montagne di cui resta questa piccola poesia «Siamo come le montagne, ognuno al suo posto sotto il suo pezzo di cielo». Tutto questo raccontava Delia Artaldi Borelli, professoressa e autrice nella pagina della donna, morta nel giugno 2018.
Delia fu attiva nel volontariato, nella cultura e nel giornalismo fra gli anni fra il 1966 e il 2000, quando non c’era molto spazio per le donne e dove seppe conquistarsi un suo spazio con competenza e determinazione. Laureata in Economia e commercio alla Bocconi è diventata preside in diverse scuole della Bassa. Fu anche consigliere comunale dedicando la massima attenzione alla sua città nella quale sentiva il bisogno di essere «dentro» i problemi. Fondò con altri trevigliesi negli anni Novanta il «Club Unesco il Caravaggio», con sede a Treviglio e con parecchi aderenti, tra i quali Trento Longaretti. Delia Borelli aveva chiara un’intenzione: dare e fare spazio ai valori femminili non per farsene vanto bensì per cercare attorno a essi l’adesione ad idee di fede autentica e di libertà creativa. Tra i suoi articoli ne spicca uno in cui Delia Borelli si destreggia tra la difesa dell’immagine della donna espressa nella «Laborem exercens» di Giovanni Paolo II e i contestatori che sostenevano quanto l’enciclica fosse ancora legata ad uno stereotipo femminile come quello dell’antica iscrizione funeraria incisa sulla tomba di una matrona romana «Domun servavit, lanam fecit» (Visse in casa filando la lana).
Suor Maria Boschi: il suo sguardo mite e buono sulle alunne della Capitanio
Suor Maria Boschi ha incarnato per anni spirito e promessa della Scuola Capitanio. Vi tornò per l’ultima volta, dopo 11 anni di assenza per riposare accanto alle sue collaboratrici: Suor Angela Maria Rossi e Suor Rosa Maria De Angelis. Vi entrò la prima volta nel 1924, giovane neolaureanda in lettere classiche presso l’Accademia scientifico letteraria di Milano. Alta, imponente e sorridente.
I ricordi di Suor Pierina Tadiello nel corso del funerale raccontano di una persona di eccezione, grande nella sua umiltà. Spesso era circondata dalle alunne che le si stringevano attorno durante l’intervallo nei lunghi e spaziosi corridoi, mentre partecipava alla loro gioia, godeva della loro vivacità o, appartata, parlava ed ascoltava, con interesse e serietà, le confidenze di una scolara con una pena da sollevare o un problema da risolvere. In classe amava sedersi davanti ai primi banchi, per poter comunicare meglio il suo animo sensibile e per rendere piacevole e più comprensibile la materia. Le alunne l’ammiravano per la nobiltà del tratto, per la versatilità del suo ingegno, che si manifestava nella parola facile, nello scritto sicuro e brillante, nel vivere poeticamente situazioni e ricorrenze, ma molto più per la dedizione costante e alacre al dovere.

Nei suoi 40 anni di insegnamento (e 34 di presidenza) alla «Capitanio» quante generazioni di mamme, di insegnanti, di lavoratrici sono state da lei formate. Quanto lavorasse per la scuola lo poterono costatare gli ispettori e i commissari che si succedettero nelle diverse tappe della vita della scuola «Capitanio»: la parificazione all’Istituto magistrale nel 1937, la trasformazione di questo in Ginnasio liceo, per desiderio di S. E. il Vescovo Bernareggi compiuta nel 1951, gli anni duri della guerra 1940- 45. Nell’archivio della scuola si conservavano lettere di ringraziamento e scritti vari ricchi di umano sentire e di fede profonda. Tra le sorelle portò sempre serenità e disponibilità: era pronta ad accogliere e ad aiutare tutte, specialmente le studentesse. Amava i poveri e, instancabile, nei momenti di riposo lavorava ad uncinetto per essi confezionando corredini per neonato, vestine, sciarpe per soldati, ecc. Era inoltre religiosa autentica: in chiesa con lo sguardo fisso al tabernacolo, la corona in mano, immobile, senza libro, senza muovere labbro trovava i suoi momenti più belli. Nel 1964 fu colpita da paresi e venne trasferita in infermeria dove continuò ad essere educatrice, preparando le infermiere agli esami, insegnando la lingua italiana alle suore straniere, continuando la sua opera di assistenza ai poveri con lavori da lei confezionati. Morì serena anche se ormai, senza l’uso della parola, parlava con gli occhi e con il sorriso. Suor Maria Boschi moriva nel febbraio 1975.
© RIPRODUZIONE RISERVATA