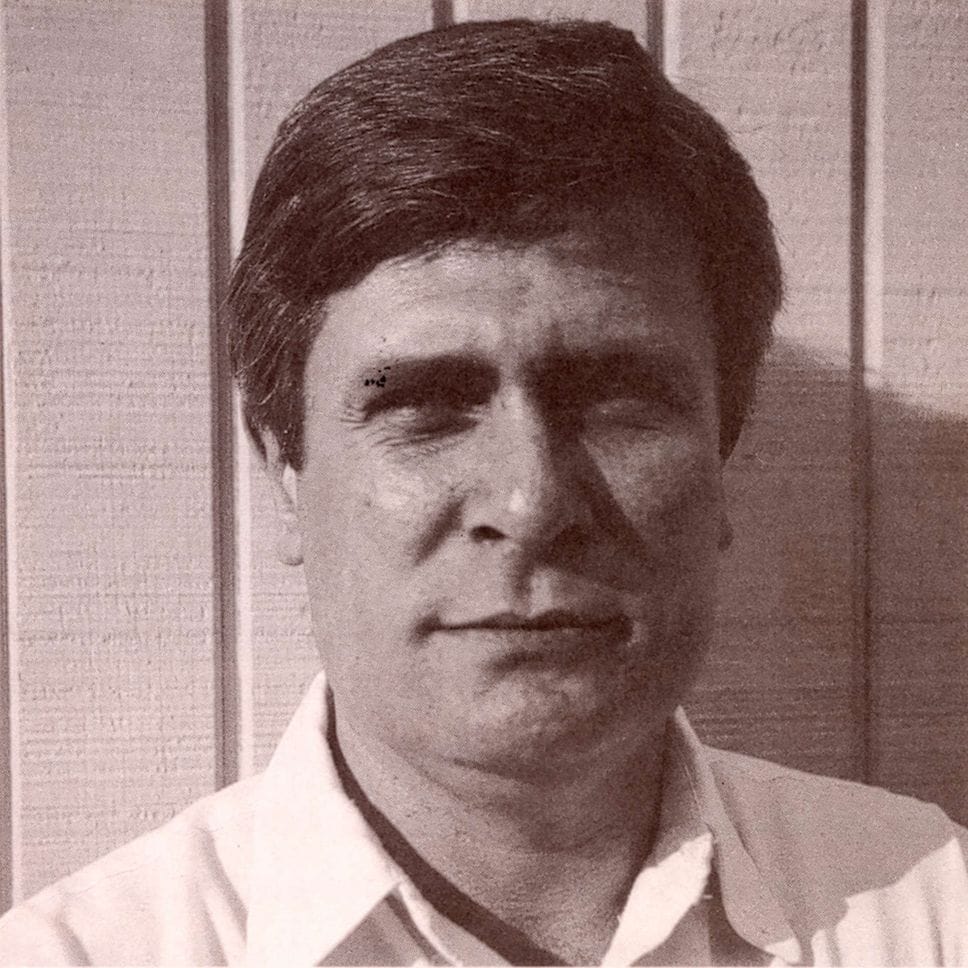Ogni vita un racconto / Bergamo Città
Martedì 11 Novembre 2025
Il vuoto che lascia la «metà» che manca
Tra i viali del cimitero, vedove e vedovi affrontano ogni giorno il vuoto lasciato dalla metà perduta. Alcuni con il passo deciso di chi sta assolvendo il suo compito, altri con il passo appesantito dal dolore che non passa
Nel viavai del cimitero di questi giorni, ci sono alcuni personaggi molto caratteristici che si mescolano ai visitatori che si vedono solo al «ponte» di Ognissanti. Li si può incontrare anche ogni lunedì mattina, o ogni giovedì pomeriggio. Oppure tutti i giorni. Sono i vedovi e le vedove che hanno perso la loro «metà». Buona o cattiva che fosse, era «l’altra metà» e, che sia passato tanto o poco tempo, resta sempre «la metà che manca». Un occhio attento sa distinguere il dolore tipico dei vedovi uomini e delle vedove donne. Se queste ultime riescono a mettere in campo nuove abitudini e sostituiscono, ad esempio, la lettura ad alta voce fatta al marito, con una lettura sommessa e rimpiazzano la pulizia del pavimento con quella della lapide, gli uomini vengono piegati dal dolore e si muovono abbracciati al vuoto che entra ad abitarli. Il libro di Benedetta Palmieri «I funeracconti» (ed. Feltrinelli), descrive con delicatezza alcuni dei momenti più forti della vedovanza al maschile.
La moglie giovane
«Mia moglie è morta, spiazzandomi. Non ero pronto, noi uomini non siamo fatti per essere lasciati soli. Forse è per questo che solitamente in una coppia l’uomo è il più anziano: scegliamo (!) donne più giovani per poter morire per primi. E quando a un certo punto della nostra vita ne scegliamo di più giovani ancora, non è per sentirci virili. Ciò che ci allontana dalle nostre compagne non è lo sfiorire della bellezza. Sono i segni della morte. Quando realizziamo che la nostra (!) donna è destinata a morire – e, diavolo, potrebbe persino pensare di precederci – è allora che rivolgiamo le nostre attenzioni a una più giovane. Con lei, ci diciamo, corriamo meno rischi. Saremo noi a lasciarla, a riorganizzare la propria vita, a trovare nuovi tempi, spazi e modi. Adesso tocca a me, ma io i miei tempi, spazi e modi non li volevo diversi. Stavo bene con mia moglie, con quelle parti della mia vita che riempiva, delle quali si faceva carico, con quelle che lasciava scoperte. Ora cambierà tutto. Con le nostre figlie, con i nostri amici, con il salumiere e con i vicini di casa. Mi sento spossato. Non ho l’età per mettermi a rodare rapporti. Ho notato che i miei capelli sono più bianchi e più sfibrati, le mani più rinsecchite e nervose».
La morte nascosta per due ore
«Quando mia moglie è morta, non ho avvisato subito le mie figlie. Avevano un importante colloquio di lavoro, e lo avrebbero annullato, ne sono certo. Che importanza ha comunicare immediatamente una morte? Soprattutto poi quando può provocare un danno che andrà a sommarsi al dolore? La morte non è qualcosa di cui si possa fare a meno, e io non volevo perdermi nulla di quella di mia moglie. Non potevo non soffrire per la perdita di chi amavo; ebbene, che la qualità della mia sofferenza fosse al migliore: profonda, vera, indagata palmo a palmo. Così mi sono fermato, e ho cercato di sistemare i miei pensieri prima di darli in pasto agli altri. Sono state due ore guadagnate alla mia vita, reinventate, rubate. Ho ritardato il succedersi degli eventi. Ho posticipato la morte di mia moglie al resto del mondo. E per un po’ è appartenuta solo a me».
A chi è giusto dare i gioielli
«Però i suoi gioielli li abbiamo guardati insieme, io e le mie figlie. La più grande mi ha chiesto se fossi contrario a che lei tenesse la fede della madre. Prima del funerale l’avevo messa nel cassetto con gli altri oggetti di valore, e al ritorno a casa – la sera stessa – ho voluto dargliela. Avrei voluto che si dividessero tutto. Tanto, ho pensato, quando morirò io – cosa che al momento mi sembra l’imminente evoluzione – dovranno comunque farlo. Quei gioielli appartengono a loro, è giusto che li prendano. Ne era convinta la madre, ne sono convinto io, ma loro si sono limitate a qualche collana, ai braccialetti, un paio di anelli. Poi mi hanno detto che di quel che restava potevo fare ciò che preferivo. A mia cognata ho dato gli orecchini di perla e il ciondolo che avevo preso per il nostro anniversario. Quello che è avanzato è tornato nel cassetto. Si può cambiare idea anche solamente per un’inezia: lo scorrere del tempo, il mutare della luce, un suono inatteso, un incontro. Può darsi che un giorno le ragazze saranno contente di trovare tutto ancora lì».
Ricordi che attraversano il tempo
Affrontare la morte delle persone che amiamo significa misurarsi con un vuoto che non smette mai davvero di interrogare. È un percorso fatto di assenze, ma anche di tracce indelebili: storie, gesti, volti, eredità affettive che continuano a vivere oltre l’ultimo saluto. Dalle nonne resilienti che hanno costruito il tessuto familiare, alle lavoratrici che hanno affrontato l’emigrazione, fino a chi ha inseguito sogni oltre oceano, questi racconti rappresentano molto più della memoria individuale: sono un patrimonio collettivo che parla di coraggio, dedizione e radici profonde.
Prima Parietti: «mia nonna, allegra e forte fino a 104 anni»
Nell’agosto 2019 Prima Parietti salutava la sua famiglia e il suo amato Borgo Santa Caterina. A 104 anni, Prima viveva sola, sbrigava ogni faccenda e scherzava dicendo di sentirsi benissimo. Oltre a nipoti e pronipoti, lasciava il figlio Isacco, 80 anni, già primario all’ospedale di San Giovanni Bianco, mentre gli altri suoi figli Mario e Lucia sono morti a pochi mesi di vita. «Mia nonna – ricordava il nipote Diego Signorelli, nostro collega – era una donna allegra e con una grinta incredibile». La sua è stata una vita di fatiche: era nata pochi mesi dopo il rientro dalla Francia dei genitori. Nel 1938 si era sposata con Giovanni Signorelli e insieme avevano aperto una macelleria. Un anno dopo il marito fu chiamato alle armi e Prima dovette dirigere la bottega. Era rimasta vedova nel 1999. Al marito è intestato l’impianto dell’Excelsior di viale Giulio Cesare.
Caterina Guerini: per lavoro raggiunse la Bulgaria con due figli
A 101 si spegneva a Casnigo, nell’aprile 2003, Caterina Guerini, vedova di Battista Imberti, la decana del paese. Viveva nella locale Casa di riposo da 18 anni. Terza di dieci figli (3 maschi e 7 femmine) e aveva lavorato per una quindicina d’anni come tessitrice nel cotonificio Dell’Acqua, che aveva lo stabilimento nella frazione Serio. Nel 1933, a causa di una crisi che colpì il settore tessile, assieme ad una ventina di altre operaie emigrò in Bulgaria dove era stato aperto uno stabilimento tessile a Sofia da alcuni imprenditori milanesi. Caterina Guerini in quell’anno era già madre dei due figli Enrico e Avelino allora in tenera età. In Bulgaria le operaie di Vertova, Colzate e Casnigo trovarono sostegno morale dall’allora delegato apostolico Angelo Giuseppe Roncalli, divenuto poi Papa Giovanni XXIII, che si recò anche a visitarle.
Armando Ghilardi: il «berga-americano» che visse a Nashville
Nell’aprile 2003 si spegneva nello Stato del Tennesee, negli Usa, Armando Ghilardi. Era emigrato quando aveva 27 anni. Così lo ricordava Ferruccio Arnoldi nel suo volume «50 storie di bergamaschi nel mondo». «La vita americana di Armando Ghirardi è cominciata nella nostra Piazza Vecchia quando incontrò una studentessa americana. Fu il classico colpo di fulmine che spinse Armando, affermato agente di commercio, a imprimere una svolta alla vita. Aveva messo da parte un discreto gruzzolo e l’Italia degli anni Settanta non sembrava offrirgli garanzie di un brillante futuro. Inoltre, trasferendosi in America, Armando avrebbe potuto realizzare più facilmente un grande sogno: conseguire il brevetto di pilota per aerei jet e volare a mille all’ora nei cieli di tutto il mondo. Così Armando Ghirardi partì un anno dopo e si stabilì a Nashville». Per tutti era il «berga-americano».
© RIPRODUZIONE RISERVATA