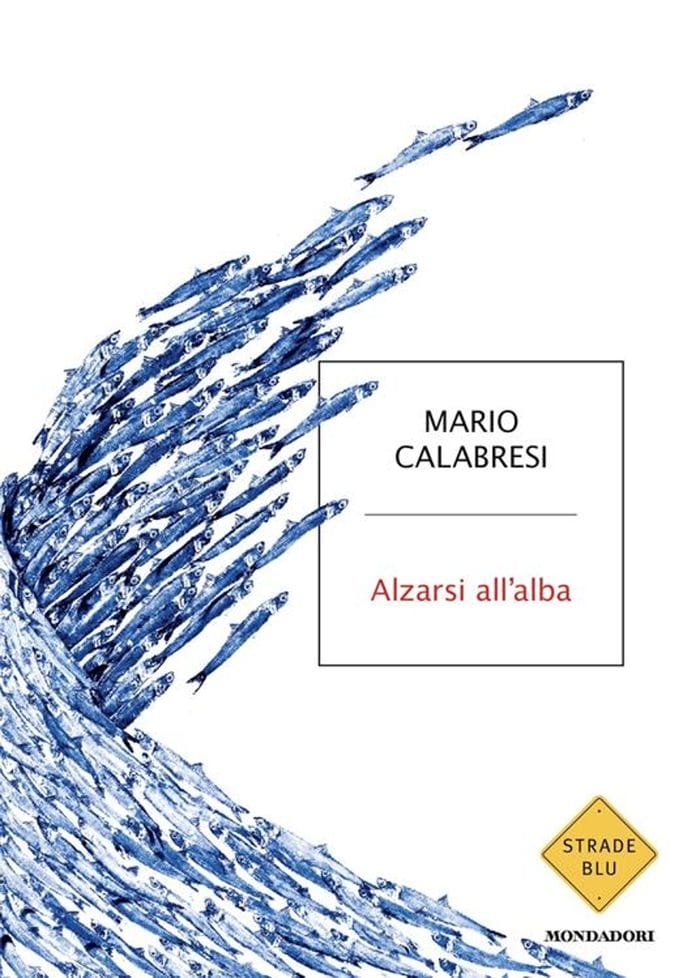Il piacere di leggere / Bergamo Città
Mercoledì 05 Novembre 2025
Calabresi e il racconto della fatica quotidiana come un inno alla vita
L’INTERVISTA. Il giornalista e scrittore sarà ospite nello spazio di Gres Art 671 per parlare del su libro «Alzarsi all’alba». Una raccolta di storie di tenacia, dedizione, sacrificio e cura, che è stata ispirata dall’incontro con l’atleta paralimpica bergamasca Veronica Yoko Plebani.
A me piace molto faticare, dev’essere una cosa che viene dalla mia famiglia bergamasca, in cui c’è questa mentalità che faticare e lavorare ti rende migliore». Veronica Yoko Plebani, nota atleta paralimpica, bronzo e argento nel triathlon nelle paralimpiadi, rispettivamente, di Tokyo e Parigi, per citare solo due dei suoi molti successi sportivi, vive a Palazzolo, sulla sponda bresciana dell’Oglio, ma, ricorda lei stessa, è di origini bergamasche. L’ultimo libro di Mario Calabresi, «Alzarsi all’alba» (Mondadori, pagine 160, euro 18,50) «è nato grazie a lei». L’autore lo presenterà in città venerdì 7 novembre, alle 18, nello spazio di Gres Art 671, per la rassegna «Librai per un anno», curata da Daniele Rocchetti (l’incontro è sold out: 500 persone prenotate, 550 in lista d’attesa).
L’insegnamento del nonno
È un libro sul valore, l’utilità, la qualità salvifica della «Fatica». E, insieme, della «Tenacia», «Dedizione», «Lavoro», «Pazienza», «Sacrificio», «Cura», «Vocazione», capacità di affrontare le «Difficoltà», come suonano alcune delle parole chiave che introducono ad altrettanti capitoli del libro. Che definiscono un sistema valoriale incardinato sull’impegno, la volontà e il piacere di spendersi, antidoti primi alla ferale «Noia». Maestro e modello di Veronica, è il nonno Dionisio, di Adrara San Martino: a 89 anni, racconta lei stessa, «fa il falegname e non si ferma mai, ogni mattina va nel suo orto al paese. Quando gli si blocca la schiena, fa una puntura di cortisone pur di non rinunciarci». Duecento anni fa, del resto, un Leopardi poco più che ventenne annotava le sue riflessioni: «La vita continuamente occupata è la più felice […]. L’animo occupato è distratto da quel desiderio innato», insaziabile, di un piacere senza confini, di una felicità assoluta, «che non lo lascerebbe in pace o lo rivolge a quei piccoli fini della giornata (il terminare un lavoro, il provvedere ai suoi bisogni ordinari...); così che è distratto da desideri maggiori, e non ha campo di affliggersi della vanità e del vuoto delle cose…».
Calabresi, da dove viene l’idea di dedicare un libro alla «Fatica»?
«Questo è un libro antico. Le prime note le ho fatte nel telefono dieci anni fa, dovevo ancora diventare direttore di Repubblica, e avevo coniato questo titolo: “Alzarsi all’alba”. Metteva insieme una serie di storie che avevano a che fare con la fatica, come quella di un cardiochirurgo che aveva una “passione mostruosa” per il suo lavoro, al quale ha dedicato tutta la vita. Ho cominciato mentre intorno a me sentivo dire che siamo entrati nell’era della comodità. Cinema, informazione, spesa, cibo, arriva tutto direttamente a casa. Ci siamo raccontati che la comodità ci avrebbe fatto vivere meglio. Abbiamo assistito nello stesso tempo a un comportamento tipico della generazione dei genitori degli ultimi vent’anni: pensare che il ruolo di un genitore sia risparmiare le fatiche ai figli. Col tempo ho capito che è vero il contrario: se gli vuoi bene gli insegni a fare fatica, ad affrontare le cose. L’amore non è togliere le fatiche, non è una bambagia soffocante, è dare la libertà di affrontare il mondo».
«Adora la fatica» è il motto che Veronica ha ereditato dal nonno: come si fa ad adorare la fatica? Sembra un ossimoro…
«Vuol dire non stare ai margini della vita, buttarsi dentro. Quando l’ho incontrata era fine inverno, mare, freddo, vento. Io avevo il giubbotto, lei stava per buttarsi in acqua per i suoi allenamenti. Ho pensato: chi glielo fa fare? Quando l’ho vista tuffarsi ho capito: c’era una tale quantità di vita nel suo gesto… in quella fatica c’era un inno alla vita».
Veronica attribuisce la sua dedizione alla fatica alla mentalità che le viene dalla «famiglia bergamasca». Secondo lei ha fondamento lo stereotipo del bergamasco lavoratore indefesso, alfiere dell’etica del lavoro?
«Credo che la cosa abbia una sostanza evidente. A Bergamo c’è un grande orgoglio per questo, e lontano da Bergamo la gente dice che i bergamaschi sono matti. Il nonno di Veronica è un esempio. Se deve lavorare e ha mal di schiena si fa fare un’iniezione dalla moglie e ancora costruisce i mobili su misura per la nipote. Non solo, ma le dice: “La prossima volta non te li potrò fare io, quindi tu vieni e impari”. La trasmissione di un sapere, di un fare, è una cosa meravigliosa».
Da una parte lei scrive che «la fatica negli anni è passata di moda», la comodità «è diventata un valore assoluto». Dall’altra detesta «l’automatismo» secondo cui i giovani sarebbero «senza spina dorsale, incapaci di impegnarsi e fare fatica». Che tanti giovani rifiutino lavori fagocitanti rifiutando l’identificazione vita–lavoro, sono però dati di fatto…
«Dati di fatto che non riguardano tutti. Gli adulti non sono certo tutta gente che lavora tantissimo. Nella mia professione ho visto gente di 20, 40, 60 anni che evitava la fatica. Oggi i ragazzi sono stati cresciuti con l’idea del tempo libero privato che si contrappone al tempo del lavoro. Io invece gli dico: fate attenzione a non dividere la vita in due parti. Anche il tempo del lavoro è tempo della vita».
Veronica, che, a causa di una meningite fulminante, ha subito l’amputazione di metà dei piedi e di diverse dita delle mani, riesce comunque a mantenere un suo entusiasmo, combatte i pensieri negativi come: «Chi me lo fa fare di vivere in questo corpo, di fare questo sport…». È fatica, impegno, lavoro anche portare il pensiero verso le cose buone della vita? Distrarlo dalla tentazione della negatività?
«Provare a vedere le cose da un altro punto di vista non credo sia fatica e lavoro. È una scommessa. Scommetto che sia più conveniente. Lei avrebbe tutte le ragioni per dire “mi è andata storta, che sfortuna, sono una vittima…”. Avrebbe ragione, ma a cosa porterebbe? Alla fine cosa faccio? mi compiango? Cosa mi regala, che vita mi fa fare, alla fine della giornata come mi sentirò? come una sconfitta. Veronica si alza, è durissima, però prova a vedere le cose positive, cerca di incoraggiarsi, la gira, può trasformare questa fatica in una passione. Lo sport è un mezzo, lei coltiva un principio, un gioco vitale che è dato dall’unicità delle nostre vite e dalla finitezza del tempo».
Se fai un lavoro che ami non lavorerai un giorno. Cosa dire ai giovani che stanno nel conflitto: mi preparo a a un lavoro che sento di poter amare, ma che presenta forti rischi di disoccupazione, sottoccupazione, ecc., o verso un lavoro che mi attira meno, ma che mi dà solide prospettive di guadagno e carriera?
«Non ho mai avuto dubbi su questo. Dico sempre ai ragazzi: “Abbiate senso di realtà”. Se voglio fare l’astronauta ma non ho le caratteristiche adatte, non è sano coltivare il sogno. A parte questo, ripeto, non ho dubbi: scegliere ciò che piace, studiare una cosa che piace, con passione. Questo è il motore vero. Se scegli qualcosa perché pensi ti faccia fare soldi diventa durissima. Devi fare scelte con la pancia, con il cuore. Il cervello ti può indirizzare, tenere in guardia, dirti cosa è realistico, ma la scelta, se ci riesci, la devi fare con la passione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA